2015
I dischi in evidenza...2015
In anni recenti l’Australia, soprattutto grazie al pionieristico tramite del chitarrista Dave Hole, che a lungo ha inciso per un’importante etichetta del settore come la Alligator, ha espresso alcuni talenti nel campo del blues. Uno di questi è sicuramente Fiona Boyes. Al pari di Hole devota della tecnica slide, Fiona è stata definita, in passato, come la “gemella cattiva” di Bonnie Raitt. Questa definizione, ancorché, per certi versi, risibile contiene in sé un nucleo di verità. Se la Boyes è sì, come la Raitt, chitarrista slide, cantante e autrice, i parallelismi, a mio modo di vedere, si arrestano tuttavia qua. Fiona Boyes, a differenza di Bonnie Raitt infatti, ha uno stile molto più oscuro e misterioso, profondo ed energico, ma di un’energia esplicitamente sinistra ed evocativa. Inoltre, questo suo ultimo Box & Dice rappresenta un esperimento strumentale che vede salir sul proscenio, oltre alle sue usuali chitarre, alcune artigianali cigar-box guitars (costruite da Shayne Soall della Oz Blues and Roots Music Store) che la Boyes suona utilizzando bottleneck ricavati da diverse piccole bottiglie di liquore e, soprattutto, una rara chitarra baritono National Reso-lectric di costruzione pure artigianale e con un unico esemplare gemello, chissà se “buono” o “cattivo”, al mondo. Il risultato, è questo agile dischetto registrato nella classica e snella formazione a trio, chitarra, contrabbasso e batteria. Fiona Boyes, qui, mescola gli stili e passa magistralmente dal Delta allo swamp al Piedmont blues, dal Texas shuffle alla Chicago post bellica. Non c’è da stupirsi se la Boyes, forte anche del suo robusto songwriting, sia stata nominata per i Blues Music Awards e sia stata la prima donna, nonché prima australiana a vincere, nel 2003, l'International Blues Challenge.


Pianista sopraffino e di grande esperienza Anthony Geraci. La sua biografia muove da una formale educazione musicale, conseguente a una precoce attitudine per il piano, acquisita presso il celeberrimo Berklee College of Music di Boston. Da lì, la sua carriera artistica lo ha portato a incidere, prima, con alcuni giganti del genere come Muddy Waters, Big Joe Turner, Jimmy Rogers, Hubert Sumlin e a essere, poi, cofondatore dei Broadcasters del chitarrista Ronnie Earl e dei Bluetones dell’armonicista e cantante Sugar Ray Norcia; band, quest’ultima, della quale fa ancora parte dopo quarant’anni di ininterrotta militanza.
Creatura androgina, dal fascino ambiguo e ombroso, la splendida cantante mississippiana Cassandra Wilson ci riprova. In questo disco, interamente dedicato a Billie Holiday - Lady Day - in occasione del centenario della sua nascita, le atmosfere dominanti sono quelle crepuscolari, notturne, a tratti un po’ inquietanti, già ampiamente sperimentate nel suo precedente capolavoro del ‘93 Blue Light ‘Till Dawn e subito replicate con l’immediatamente successivo e sempre ottimo, anche se meno sorprendente, New Moon Daughter del ’95.
Con Coming Fourth By Day la Wilson si immerge, anima e corpo, tra le pagine più schiette ed esplorate del songbook della Holiday, restituendone una lettura molto personale, anche discutibile, certamente lontana dai registri espressivi tipici di Lady Day, ma sincera, intensa e partecipata. La scura, bruna levigatezza del suo contralto profondo, dalla timbrica più direttamente riferibile a una Abbey Lincoln piuttosto che alla stessa Holiday, unitamente a sonorità e arrangiamenti che sono figli legittimi di musicisti e produttore di dichiarata estrazione gothic-rock (Nick Launay, è stato il produttore di Nick Cave & the Bad Seeds) conferiscono al disco, più che la fragile, ferita drammaticità degli originali, atmosfere più misteriose e, talvolta, stranianti. Tanto che, nell’ascoltare questo Coming Fourth By Day, par di stare in una camera con vista sulla Holiday più che immersi nel suo denso universo emozionale. Una vista dall’orizzonte più rarefatto, solo a tratti benedetta dalla chiara luce di un giorno di sole, dove il sentimento dominante è quello della vertigine, indotta dalle distanze e dagli indefiniti, talvolta irriconoscibili, contorni. E’ la lenta discesa in un maelström sonoro che reinterpreta e, forse più, riscrive l’opera stessa che vorrebbe omaggiare.
Esistono dei precedenti analoghi: il pianista Dr. John e il suo Ske-Dat-De-Dat: The Spirit of Satch, per esempio. Anche lì, l’artista ripercorreva in modo altamente personale alcune pagine del repertorio, nel caso specifico, di Louis Armstrong, di fatto, trasfigurandole attraverso la grana filtrante della sensibilità e della scrittura a lui proprie. Similmente qui, la Wilson ripercorre la strada della Holiday ridisegnandone il percorso. You Go To My Head, per dire, assume contorni quasi da Philly sound grazie agli archi arrangiati da Van Dyke Parks così come All Of Me perde il suo originale, brillante swing a favore di un’atmosfera ben più colloquiale e rarefatta.
Ai brani più famosi del repertorio di Lady Day la Wilson, aggiunge, in conclusione, l’unico brano originale di tutta la raccolta, Last Song (For Lester), immaginario, drammatico monologo che fantastica attorno ai sentimenti della Holiday in occasione della morte del suo grande amico e accompagnatore, il sassofonista Lester Young.
Quando intrapresa, la riproposizione di grandi classici non può essere solo riproposizione fedele e fine a se stessa, ma viva sfida che sa affrontare il gran mare e le sue onde abbandonando le rotte tracciate dalle carte nautiche; e chi meglio della Wilson e dei suoi qui presenti compagni avrebbe potuto fronteggiarla con conoscenza, sensibilità e, di fatto, buona riuscita nel rivelarci nuovi, inimmaginabili approdi. G.R.
Ronnie Earl ha ridotto la sua attività concertistica in terra natia al rango di pregiata rarità mentre quella nella vecchia Europa è, da tempo, inesistente. Per contro, ci ha abituati a uscite discografiche pressoché annuali e costanti. Rispetta la regola anche quest'ultimo Father's Day che, a distanza di un anno o poco di più dal precedente Good News, ci dà lo spunto per poter parlare nuovamente di lui. Dire che da Ronnie Earl si sa sempre cosa attendersi è un po' un'ovvietà; ma c'è chi lo afferma con lo spirito del detrattore e chi, invece, con l'affetto e la passione che gli sono dovuti. E noi, data l’innegabile statura artistica del personaggio, ci leghiamo, saldi nella nostra convinzione, alla seconda schiera. Di certo, da lui, ci si attende sempre qualcosa di buono tanto che potremmo estrarre, bendati, dalla sua discografia un disco a caso e sceglieremmo comunque bene. E quest'ultima fatica non fa assolutamente eccezione.
Indiscusso maestro di tono, fraseggio e intensità, la sua chitarra sa essere tanto tagliente, profonda quanto vellutata e liquida. Durante tutta la sua carriera, Earl si è sempre concentrato interamente sullo strumento lasciando il canto, a volte anche solo sporadico, data la vocazione prettamente strumentale di molti suoi dischi, a terzi. In questo suo ultimo lavoro, invece, le parti cantate dominano in quantità e sono equamente ripartite tra gli ottimi Michael Ledbetter, pietroso, muscolare cantante dall’emissione lirica e diaframma impostato, già voce solista nella band del chitarrista Nick Moss e Diane Blue, passionale cantante e brillante armonicista dai trascorsi, anche discografici, solisti, prima donna a far parte dei Broadcasters. Dai precedenti lavori di Earl, quest'ultimo Father's Day marca la differenza, dunque, per spirito, stile e rinnovato interesse per il blues quale forma canzone. Dedicato al padre Akos recentemente scomparso (da qui, il titolo), spariscono quasi completamente le incursioni nei territori latini alla Santana e del jazz mentre ritorna protagonista prepotente e assoluto il blues, quello intenso, di matrice chicagoana come la vibrante versione di Right Place, Wrong Time seconda solo all'originale di Otis Rush o gli ottimi, molteplici tributi a Magic Sam o il soul-blues con la cupa ballad in minore I'll Take Care of You o, ancora, l'inatteso Givin' Up, brani rispettivamente divenuti “classici” sulle ugole di Bobby “Blue” Bland e Donny Hathaway. Con Moanin' Earl si ritaglia un piccolo spazio per le vecchie abitudini strumentali e, in chiusura, l'ultima sorpresa, che ci accompagna al saluto, è quella sacra di Precious Lord, riconciliante preghiera laica, metaforico accostamento tra le figure del padre secolare, scomparso, e del “prezioso” padre celeste. Nel disco, l'Hammond dal timbro chiaramente "churcy" è quello di Dave Limina, mentre la batteria è quella precisa e vigorosa di Lorn Entress; a completare l'organico, oltre al fedele basso di Jim Mouradian, il ritorno, tra i Broadcasters, di una sezione fiati, qui incarnata da un robusto duo di sax con protagonisti Mario Perrett al tenore e il talentuoso Scott Shetler al baritono a rendere più rocciosa la parete sonora. G.R.
Niente DOC, DOCG o IGP, ma l’affermazione riportata sul fondo della copertina ne certifica piuttosto il contenuto come CHB, ovvero “Contemporary Hokum Blues…”. Col termine “hokum blues”, ci ricordano autorevoli fonti accademiche, si vuole intendere quel blues, talvolta improvvisato, anche un po’ sempliciotto e scanzonato, imbottito di doppi sensi a prevalente carattere sessuale, mutuato di fatto dai minstrel shows e dal vaudeville, diffusosi nei primi decenni del ‘900 per bocca di artisti come Tampa Red, Gus Cannon e Casey Bill Weldon, per dirne alcuni, e rivolto a un pubblico magari ingenuo al fine di strappargli, con modico sforzo, una grassa risata. Stando alla definizione, se quello di Bad News Barnes è hokum blues, di certo non parrebbe rivolto alle menti semplici; o, forse, sarà mica quel “contemporary” a voler sottintendere un’evoluzione del genere e, dunque, del pubblico? Tutto può essere! Fatto è che ciò che propone Bad News (al secolo, Chris) Barnes è arguta satira sociopolitica in forma di blues; musica per riflettere e, certamente, per ridere giacché – penserà Barnes – chi non ride, non può essere una persona seria.
La carriera di Barnes è sempre stata in equilibrio instabile tra teatro, televisione e musica e, dopo aver partecipato a diversi, celebri programmi televisivi americani, è tornata a sbilanciarsi sul blues con questa doppia uscita: cd, of course, e un dvd contenete quattro video di brani già in scaletta in versione audio più un bonus, Someday Baby, con Felicia Collins. Se anni fa i veneziani Pitura Freska auspicavano un papa nero in Vaticano, beh, Barnes esordisce spingendosi oltre inneggiando, con l’introduttiva America Needs a Queen, a un presidente ben più che femminile. Parte, poi, la lunga raffica di dissacranti parodie di brani celebri: Shake, Rattle & Roll diventa Salt, Sugar & Fat, Come On di Earl King diventa Hungry And Horny e, siccome anche la chiesa sta sulla linea di fuoco di Chris Barnes, Ode To Billy Joe di Bobbie Gentry diventa arguto dileggio del perbenismo e dell’ipocrisia chiesaiola in Westboro Baptist Blues, cantata in compagnia di Dana Fuchs e Felicia Collins. A completare il quadro la comica, divertentissima Post Op Transgender e alcune cover tra le quali spiccano Going Down di Don Nix e la conclusiva My Ding-A-Ling di Dave Bartholomew. Musicisti stellari ad accompagnarlo e una robusta sezione fiati formata, mi piace ricordare, da Tom “Bones” Malone al trombone, “Blue” Lou Marini al sax tenore e, da ultimo, il leggendario e recentemente scomparso Lew Soloff alla tromba, già con Blod Sweat & Tears, Lou Reed, Aretha Franklin ed Elvis Costello.
In conclusione, scomodando ancora l’enologia, Bad News Barnes è come dovrebbe essere lo spesso sottovalutato Lambrusco: mosso e brusco. G.R.
“I Ain’t Lyin’…”: il titolo è anche la gergale affermazione ripetuta da Musselwhite, quale insistita interiezione, nello svolgersi del disco, ma è altresì metafora di autenticità e schiettezza, qualità che ben si applicano alla storia di questo vecchio ragazzo del Mississippi, in arte armonicista e cantante. Registrato dal vivo in due occasioni distinte, rispettivamente al Valley of The Moon Vintage Festival in California e al Clarksdale Soundstage in Mississippi sul finire del 2014, il disco ci restituisce un Musselwhite in piena forma, supportato dal suo attuale trio di competenti giovanotti, formato dal talentuoso Mattew Stubbs alla chitarra, Steve Froberg al basso e June Core alla batteria. Il programma qui presentato include quasi interamente brani autografi ad eccezione della celebre Done Somebody Wrong di Elmore James e del Christo Redemptor di Duke Pearson (inciso, in origine, dal trombettista jazz Donald Byrd nel meraviglioso album Blue Note A New Perspective) che Musselwhite già interpretò nel suo primo, leggendario disco Stand Back; correva l’anno 1967.
Anche con questa nuova uscita, Musselwhite conferma il suo status di gran maestro dell’armonica. Abbandonate ormai le divagazioni etniche che, occasionalmente in passato, l’hanno condotto a mescolare la sua musica con suoni altri, caraibici o latini, pare definitivamente tornato all’ovile, nel cuore di quel Delta, origine di tutto, qui lievemente trasfigurato nei tratti dal personale percorso dell’artista. L’atmosfera che domina l’opera è, sì, quella del juke joint, ma la capacità di Musselwhite di scoprire e farsi accompagnare da nuovi talenti unitamente al suo personale percorso artistico, marcano la differenza nel suono e nell’effetto finale. Memoria e novità, si potrebbe dire: l’esuberante, affilata chitarra del giovane Stubbs e la secca, potente ritmica del duo Froberg-June infondono modernità al rigore della tradizione. Ormai formazione rodata e affiatata, costituisce il contraltare ideale al protagonista che, lungo le tracce del disco appare divertito e scanzonato come in Long Lean Lanky Mama e 300 Miles To Go quanto più introspettivo e partecipe in Always Been Your Friend, My Kinda Gal o Blues Why Do You Worry Me?.
Si dice che gli artisti si allontanino dal mondo e al mondo, poi, ritornino per mezzo di quella metafora che è l’opera stessa. Per mediare da questo detto una definizione che aderisca a Musselwhite si potrebbe dire che il suo percorso artistico ha preso la forma della spirale: ritorna sulla stessa linea del punto di partenza marcandone, però, uno scarto. Quello scarto che è il risultato delle esperienze, delle collaborazioni, delle contaminazioni, della mescolanza con giovani energie e delle influenze reciproche, ben riassunte in questa sua ultima incarnazione, compendio di un lungo viaggio di ritorno alle rinnovate origini. G.R.
C’è un’idea di incombente minaccia nei pesanti cieli di piombo e nel bianco e nero diffuso di questo By The Lonely Lights Of The Blues, opera settima – se ho fatto ben di conto - di Luciano Federighi, critico musicale, saggista, scrittore in primis e, parallelamente, autore, musicista, cantante.
La svaporata, ma carica gradazione del cd come quella della copertina e del booklet rimandano a un racconto talvolta sospeso, incompiuto, al sentimento di straniamento o al senso segreto del viaggio di un'umanità raminga, variamente sofferta, ripiegata in un intimo avvitamento tra il sentore di sovrastante abbandono e precarietà, lato ‘B’ di un 'American Dream' tutto luci e dollar bills.
Come e forse anche più che in precedenti suoi lavori, qui trionfano il lirismo e il dotto, immaginifico bozzetto. I riferimenti stilistici spaziano dalle atmosfere di Nat King Cole e Charles Brown, alla sommessa ironia di Mose Allison o di un Dave Frishberg, alla raffinatezza di Randy Newman fino al primo Tom Waits, quello magari un po’ più sommessamente crepuscolare. Tutti – mi accorgo ora – pianisti. Di quest'ultimo ritornano, non certo gli aspetti dannati, i fumosi night o le bettole di periferia, quanto i toni più squisitamente narrativi, alla Closing Time, per dire. Non c’è la sua voce torbata di catrame e whisky, ma un baritono bruno, nasale, dalla più rassicurante, paterna tonalità. Il racconto non è quasi mai immediato e di pronta fruizione, ma più frutto di una ricerca della parola, della frase, del gioco verbale, dell’affabulazione.
Muove da una breve, spettrale introduzione di fanfara il cupo, immaginifico invito di Percy Mayfield in A River’s Invitation, unica cover di questo pregevole, omonimo dischetto, opera quarta dei The California Honeydrops, band multietnica fresca di gioventù e di idee. Muove da un andamento sinistro, ma evolve ben presto verso un pigro e quasi giocoso compimento. Pur ben lontano dall’eloquio di Mayfield, il cantante e multi strumentista, Lech Wierzynski, sulle punte di una voce fine e vibrante, restituisce l'invito sirenoide del fiume ("...if you can't find your baby, come and make your home with me...") con tono di indolente rassegnazione, sottolineato da una chitarra liquida e un sax graffiante, entrambi efficacemente minimali e concisi. Come detto, brano singolare e unica cover di un disco che prosegue con composizioni tutte originali che risentono delle influenze più variegate. Si parte dal Marvin Gaye prima maniera della successiva, fresca When It Was Wrong per giungere alla carnalità e alla veemenza churchy, sapientemente incastonate nell'originale controcanto dei fiati più che nella pur insinuante interpretazione del cantante, del soul-blues di Cry Baby Blues. Oltre le influenze neorleansiane e Motown, nel disco spuntano anche un paio di spumeggianti episodi reggae. Al netto del lento strumentale Lead Me Home che forse ben altra sorte avrebbe potuto avere che non quella di probabile riempitivo se fosse stato benedetto dalla presenza di Wierzynski e della sua ugola, tutto il resto suona scorrevole e organico nell’insieme.
Tromboni, chitarre, conga, coriste ampliano il quintetto base in diverse occasioni. Tra gli strumentisti aggiuntivi, Nick Otis, nipote del più celebre Johnny (Otis, s’intende), alla batteria. G.R.
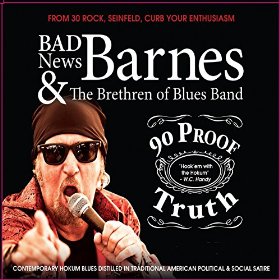

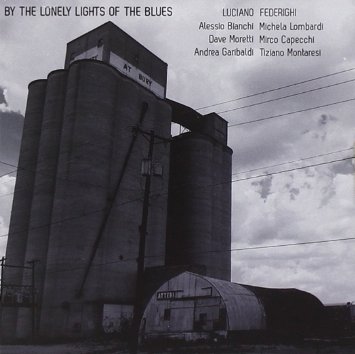
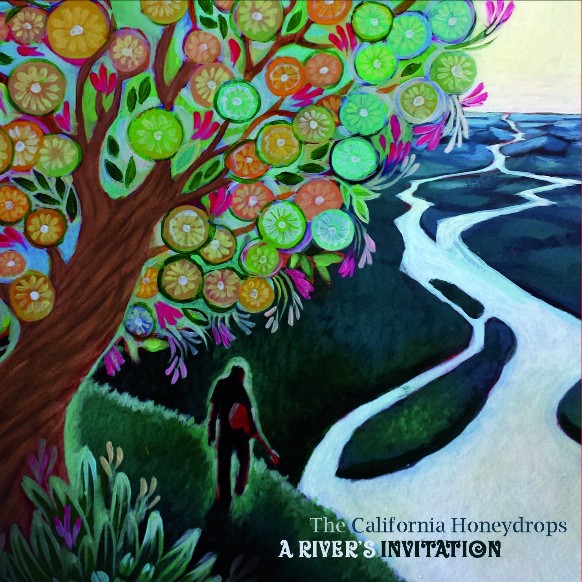
Tra gli ultimi bluesman viventi ad aver attinto l’arte direttamente dai grandi maestri del passato, Doug MacLeod è, oggi, unanimemente considerato superbo autore e virtuoso chitarrista. Californiano d’adozione, muove lì i suoi primi passi come sideman richiesto da artisti quali Pee Wee Crayton, Big Joe Turner e George “Harmonica” Smith, per poi esordire, quale chitarrista elettrico, nel 1984 con il disco No Road Back Home. E se nella seconda metà degli anni ’80 proprio dalla California arriverà quella sintesi di soul, blues e finanche pop che darà nuovo slancio, pure in termini commerciali, al genere, proprio sul finire degli anni ’80 MacLeod mette fine alla sua esperienza di chitarrista elettrico dal taglio moderno per dare il via a una metamorfosi che, ancora lontano dalle mode a venire, lo porterà alla riscoperta del blues acustico. Appartenente alla più vasta e nobile categoria degli storytellers, cantante dagli agri accenti soulful, autore dai richiami diretti alla poetica e all’arguzia del blues più genuino, anche in quest’ultima uscita discografica (la terza per la Reference Records) rimane fedele ai propri stilemi unplugged. Accompagnato dalla devota ritmica di Jimi Bott e Danny Croy, già presenti nel precedente There’s A Time, a questi si aggiunge l’ottimo pianismo di Michael Thompson, anche lui di ritorno in famiglia con MacLeod dopo i recenti tour con gli Eagles. Il programma, che si svolge lungo le undici tracce del disco, muove proprio da Rock ‘Till The Cows Come Home, omaggio allo scanzonato e divertito Louis Jordan, che funziona proprio bene da proscenio per il gustoso piano di Thompson. Il MacLeod più intimista e filosofico, invece, si rivela in Find Your Right Mind, mentre numerose sono, dopo il brano iniziale, le altre ispirazioni. Sebbene, come sempre, i brani siano intero frutto della penna di MacLeod, musicalmente i tributi sono diversi: Vanetta è un boogie a la John Lee Hooker così come il successivo Serious Doin’ Woman risente degli echi di Tony Joe White. New Morning Road, invece, è un omaggio al vecchio Ernest Banks, maestro del Piedmont blues e tra i primi mentori di MacLeod. Non poteva, poi, mancare un tributo alle donne: Raylene è tipo che, a differenza della celeberrima coeva “baby child” cantata da Muddy Waters, “…makes love like a woman, but she’s nineteen years old…”. Sul finire, rispunta il MacLeod introspettivo di Heaven’s The Only Place e, il tutto si chiude, un po’ così come s’era aperto: dove l’ispirazione, all’inizio, era rivolta a Louis Jordan, qui la troviamo indirizzata a riscrivere un Duke Ellington in forma di parafrasi. You Got It Good è, infatti, chiusura degna nonché rappresentativa del sentimento dominante nell’ascoltatore una volta giunto al termine dell’ascolto di questo disco….and that really ain’t bad, Doug!!! G.R.
Tra le cantanti favorite dello storico circuito del cosiddetto Northern Soul, Bettye LaVette taglia artisticamente i denti negli anni ’60 incidendo per la benemerita Atlantic. Transitata, successivamente, attraverso varie etichette minori per poi rientrare dalla porta di servizio in Atlantic attraverso la sua sussidiaria Atco, conosce un periodo di stallo nella palude della disco music quando, tra gli anni ’70 e ’80 questa imperversava. Ma solo negli anni 2000, grazie a una più assidua frequentazione con gli studi discografici e produzioni accurate riesce, piccola botte, a dimostrare la matura qualità del suo vino. Così, a partire da A Woman Like Me del 2003, ancora oggi con quest’ultimo Worthy dimostra pienamente di essere, più che mai, padrona del proprio gioco.
LaVette è strumento vocale acidulo, ghiaioso, dalla grana talvolta grossa, le cui corde arrivano a piegarsi in drammatica frattura come nell’intimistica ballad Bless Us All. Al pari del precedente disco, I’ve Got My Own Hell To Raise, anche per quest’ultimo Worthy, il produttore è Joe Henry. Personaggio ben più sensibile alla creazione delle giuste, spesso sommesse, segrete atmosfere che ai trucchi da tecnico del mixer, Henry lascia anche qui il necessario, vitale, respiro alla cantante che, sebbene sempre solo interprete di brani altrui (qui ritroviamo cover di Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles…), dimostra una volta in più di essere abile nel reinventare la canzone, trasformandola in qualcosa di sua piena proprietà.
Ottimo il lavoro gregario della band qui formata principalmente da Doyle Bramhall alla chitarra, Chris Bruce al basso e Patrick Warren alle tastiere che, grazie a un sensibile supporto interamente volto al risultato, lascia che il diamante grezzo della LaVette risplenda libero lungo tutto un disco, dalla cifra stilistica estremamente personale e nel quale ben difficilmente si riuscirebbero a individuare i brani più significativi, rimandandone l’esercizio al puro gusto personale dell’ascoltatore. G.R.



