2019
Recensioni > Shortcuts > Anni precedenti
Shortcuts: i cd in breve...2019
Shortcuts: i cd in breve...: in questa sezione del sito, troverete le recensioni delle novità discografiche, ma in versione compressa!
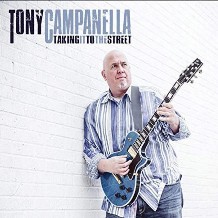
TONY CAMPANELLA
"Taking it to the street"
Gulf Coast Rec. (USA) - 2019
Taking it to the street/Pack it up/One foot in the blues/You don't know/Good morning little school girl/Finger on the trigger/Mr. Cleanhead/Checking on my baby/Texas chainsaw/My motor's running/Those are the times
Nell’attraversare la sottile linea di confine tra forme tradizionali e più moderne sonorità, lo spartiacque resta la tonante chitarra di Tony Campanella, spesso sospinta sul versante più rock del genere blues come nella title track, nella personale rivisitazione di Good Morning Little School Girl o in Finger On The Trigger.
Talvolta espressamente debitore di Stevie Ray Vaughn come in Pack It Up - inedito da non confondersi con l’omonimo pezzo di Freddie King! - o parimenti di Albert King e Gary Moore rispettivamente in Checking On My Baby e Those Are The Times (quest’ultima, ben da vicino ricorda Need Your Love So Bad), si dimostra anche interessato a un suono più paludoso e ossessivamente terragno come in Texas Chainsaw, quando non ammiratore di Albert Collins come nella rivisitazione del Mr. Cleanhead di Eddie Vinson.
Accompagnato dalla regolare road band di Mike Zito, oltre che da Zito stesso alla chitarra ritmica, Taking It To The Street rappresenta, di questo chitarrista di St. Louis, l’esordio discografico. G.R.

ODDS LANE
"Lost & found"
Gulf Coast Rec. (USA) - 2019
Don't give it away/Seven states/I ain't missing you/Lost and found/Moth to a flame/Hard rain/Blood on the van/Spare change/What's your name/Little too late/White castle blues
Qualcuno, con un repentino, verticale volo di fantasia, li ha definiti dei moderni Steely Dan! Prendiamo pure l’affermazione come l’iperbole che è sintetizzando, dalla stessa, il suo più probabile significato: questo dinamico duo di St. Louis è interprete di un suono robusto che pesca dalle più diverse influenze: blues, rock, roots, americana e restituisce una moderna miscela che tradisce pure una qualche intelligente sensibilità pop. Ma degli Steely Dan ricordano, principalmente, la grande capacità di omogeneizzare il tutto in maniera assai credibile sebbene non così identificabile e personale come fu, invece, per la band di Donald Fagen.
Ciò detto, Doug Byrkit, bassista, e Brian Zielie, batterista, di sicuro, hanno idee e sono ottimi autori con una vena blues sempre, comunque ben marcata e presente, in maniera evidente o sotto traccia, grazie alla slide di Mike Zito, gradito ospite. Malgrado calchino le scene da quasi vent’anni e questo non sia il loro primo disco, solo adesso stanno vivendo una nuova giovinezza riscoperti proprio da Zito, sull’onda della recente ristampa della sua opera prima, quel Blue Room che vedeva presenti i nostri due quale sezione ritmica. E, così, è ancora Zito a produrre questo Lost & Found che, nell’economia complessiva, beneficia di un missaggio e di una coesione di suono finalmente efficaci, opera del pluridecorato di Awards, David Z (Prince, Buddy Guy, Etta James…). G.R.
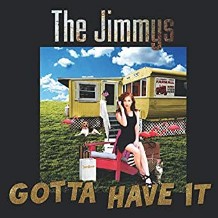
THE JIMMYS
"Gotta have it"
Brown Cow Rec. (USA) - 2019
Ain't seen nothin' yet/Grim reaper/Write a hit/She gotta have it/Started up again/Hotel Stebbins/Drinkin'/When you got love/Always a woman/Words and actions/Someday baby/Take you back/Jose
Guidati da quel diavolaccio di Jimmy Voegeli, compositore, cantante e tastierista, The Jimmys sono quell’infuso denso di soul, blues e fiati che da una dozzina d’anni in qua, viene distribuito, in generosi boccali alla spina, nei pressi dei principali palchi da festival e roadhouses di mezza America. Questo loro ultimo lavoro, prodotto da quel vincitore di Grammy che è Tony Braunagel, vede anche la presenza, quale preziosa e gradita ospite, di Marcia Ball nella doppia veste di autrice e cantante. Come autrice, firma e duetta con Voegeli in Write A Hit, sagace e sdrammatizzante racconto, in salsa neorleansiana, di una separazione tra coniugi e della conseguente spartizione dei propri beni materiali. Mescolata alla gustosa slide guitar di Greg Koch, l’aria della Big Easy ritorna in pieno spolvero, schietta e verace, con When You Got Love, insieme alla Ball, qui solamente cantante.
Ma, nel complesso, al netto dell'alcolico Drinkin’, nel quale riemerge tutta l’anima di Jimmy Liggins mano nella mano con quella della sua epoca e lo slow blues canonico Someday Baby, ciò che resta del disco si muove, assai convintamente, sul sentiero polveroso di quel rockin’ blues da balera che già diverse altre party bands frequentano: qui, talvolta più ricco, articolato e inventivo. G.R.

DIANA REIN
"Queen of my castle"
Gulf Coast Rec. (USA) - 2019
Yes I sing the blues/The midnight line/Queen of my castle/I can't quit you/One foot in/Walking along/Pure soul/It's you/My love/Get down/Chill of the night/Worth/Time's ticking away/Heat/Zoe
Nello strumento, solido e persuasivo, di Diana Rein troviamo, in primis, un certo policromo retrogusto: talvolta di Buddy Guy, altre di Stevie Ray Vaughn. E questo, per una metà del disco; quella che, in prima approssimazione, potremmo identificare come la più schiettamente blues. Perché c’è n’è una seconda dove, invece, la Rein libera i suoi più sinceri istinti rockettari che culminano in Heat e poi Worth, forse il brano più dotato, anche nel senso di un qual certo appeal radiofonico.
In evidente contrasto col suo chitarrismo deciso, anche inventivo, ma mai inutilmente muscolare, una voce alta, leggera, dal timbro sensualmente acerbo e adolescenziale malgrado l’anagrafica della nostra “regina” tradisca il correre del suo quarto decennio di regno. Il disco, interamente composto da inediti e prodotto da Michael Leasure, già batterista di Walter Trout, si chiude con lo strumentale Zoe, hendrixiano nel proprio personale ripercorrere il sentiero di Little Wing. G.R.

RAE GORDON BAND
"Wrong kind of love"
Autoprodotto (USA) - 2019
Comin' back for more/Don't look now/How you gonna/Might as well be you/Sea of blue/Wrong kind of love/How much I love you so/Got to have you/Last call/Get right with the world
Di questo Wrong Kind Of Love, ampia osservazione sull'amore e sulle sue molteplici e prevalentemente infauste angolature, il lento, minore Sea Of Blue si candida a essere il brano assai più rappresentativo nel quale la band mostra, a tutto spolvero, la propria struttura reggente: organi caldi, chitarre intense, originali soluzioni fiatistiche. Il ruspante contralto di Rae Gordon, dalla corpulenta e familiare sincerità trova qui, e in ogni occasione in cui il ritmo rallenta, come nell'accorato soul How You Gonna, la cornice più confacente al suo strumento verace e privo di fronzoli. Se, la Gordon, sui tempi lenti riesce, con più agio, a modulare tutta la propria schietta espressività, non mancano, lungo tutto il disco, sfumature cromatiche ben differenti come il funk dell'introduttiva Comin' Back For More o la conclusiva e vagamente sanctified Get Right With The World.
Registrato e mixato da Jimi Bott presso il suo Roseleaf Recording Studio, Wrong Kind Of Love è la quarta uscita della band, ma la prima a proporre un programma di soli inediti, frutto di una penna genuina come la torta della nonna. G.R.

KERN PRATT
"Greenville, MS...what about you?"
Endless Blues Rec. (USA) - 2019
Loving that feeling/Hard working man/Baby's got another lover/Torn between love and hate/Something's gone wrong/Rita/Way she wears her clothes/Nola/Whatcha gonna do?/Chicken heads
Capace di esprimere morbide sonorità blues e paludosi impasti a là J.J.Cale, il mississippiano Kern Pratt, chitarrista dal fraseggio distinto, mostra di preferire la ricerca del tono, delle dinamiche e delle intuizioni melodiche al profluvio strumentale. Il suo carattere musicale sfuggente, scivola svelto tra quelle mani che cercano di afferrarne l’essenza tanto che, la stessa, mai si rivela chiaramente al primo ascolto. Ma tra le pieghe ripetute del suo tessuto, emergono lontane tracce del vecchio Little Milton, soprattutto laddove i blues si fanno lenti e infarciti di fiati.
Questo suo ultimo disco chiama a raccolta alcuni tra i moderni sessionmen in circolazione, come Bill Ruffino e Jeff Jensen, entrambi impegnati nella conclusiva rilettura di Chicken Heads, vecchio hit funk scaturito dall’arguta penna di quell’altro esponente del profondo sud che è Bobby Rush. Al netto di quella Rita che scivola via facile sulle note di un pop notturno da radio FM e di Nola, palese omaggio alle vicine terre della Louisiana e, in particolar modo, a New Orleans, tutto il resto sembra diretta emanazione di quella Greenville, richiamata nel titolo, che in tanti riconoscono essere quel punto centrale nell'evoluzione della musica - e dell'arte! - in America. G.R.

JAY GORDON'S BLUES VENOM
"Slide rules!"
Shuttle Music Rec. (USA) - 2019
Dripping blues/Pain/Lost in time/Lucky 13/Dockery's plantation/Stranger blues/Voodoo boogie/El diablos blues/Travelin' riverside blues/Pure grain alcohol/Six-string outlaw/Sweetheart blues/Train train
Feroce e carica di grezza, metallica energia è la slide guitar di Jay Gordon, moderno interprete di un blues, vigoroso e un po’ scortese, che afferra a piene mani la tradizione di Elmore James e Robert Nighthwak e la combina con il nervoso sferragliare di Johnny Winter. Un Eric Sardinas dei giorni nostri, insomma, che, a capo dei suoi Blues Venom, classica formazione a trio (sebbene, qua e là, faccia capolino un tastierista non menzionato nelle note di copertina!), si cala in trincea e apre il fuoco con sventagliate elettriche di boogie e delta blues che concedono poco scampo e ancor meno respiro.
In mezzo a una generosa dose di inediti, incluso qualche buon roadhouse rocker, Gordon sceglie di inserire un tris di personali, talvolta sorprendenti riletture: tra queste, meritano sicura e singolar menzione il rifacimento acustico del Robert Johnson di Travelin’ Riverside Blues e la conclusiva Train Train, già interpretata negli anni ’70 da J. Blackfoot, qui trasfigurata da tanta bruciante furia. G.R.

SISTER LUCILLE
"Alive"
Endless Blues Rec. (USA) - 2019
Won't give it/Alive/See my baby/Devil's eyes/Wanna love you/99 pounds/Respect your woman/Fussin' & fightin'/Thinking about you/W-o-m-a-n/Lost
Sister Lucille non è, come si potrebbe pedestremente pensare, lo pseudonimo della bella ragazza in suadente mostra sulla copertina (che, diversamente, di nome fa Kimberly Dill), ma proprio il nome di questa band del Missouri di cui, la suddetta ragazza, è la cantante. Sister Lucille è l’ultima, interessante, scoperta del sempre attivo Mick Kolassa; lontano frutto dell’International Blues Challenge del 2015, il quartetto base, qui talvolta completato da fiati e Hammond, trova nel magico interplay tra lo strumento vocale, felino e sinceramente torrido, della Dill e la vigorosa, ma sempre raffinata chitarra di Jamie Holdren, il proprio centro di gravità permanente.
Alive, prodotto da Jim Scott, già produttore della Tedeschi Trucks Band, offre un completo e moderno spaccato di blues, roots, rock e soul che va ben oltre gli abusati e tradizionali clichè del genere e dove ogni sincero amante dello stesso potrà facilmente trovarsi a proprio agio. Anche l’eccellente songwriting, che raggiunge in Respect Your Woman, variazione femminile sul tema del back-door man, e nella sensuale e neworleansiana Devil’s Eyes le proprie massime sommità - la punta della sua lasciva tromba in sordina sospinge tra gli anfratti di Bourbon Street! - fanno di questa band un’entità compiutamente coesa e pienamente convincente. G.R.

MATTY T WALL
"Transpacific blues vol.1"
Hipsterdumpster Rec. (AUS) - 2019
Boom boom (feat. Dave Hole)/Hi heel sneakers (feat. Eric Gales)/Quicksand (feat. Kid Ramos)/She's into something (feat. Walter Trout)/Stormy monday/Born under a bad sign (feat. Kirk Fletcher)/I'm tore down/Crossroads
Che sia la risultanza di un senso di colpa per la tanta distanza dalla più stretta ortodossia blues delle sue precedenti produzioni, della nostalgia per gli approdi certi dati dalla tradizione o della semplice voglia di ammiccare al pubblico, Transpacific Blues Vol. 1, oltre a lasciar intendere l’intento di voler replicare l’operazione con un futuro Vol. 2, si rivela essere un magistrale trattato di chitarra elettrica in salse assortite e per veri amanti dello strumento.
Non ci si lasci ingannare dalla lista dei brani in scaletta perché, in questa sua ultima uscita, il giovane guitar slinger australiano Matty T Wall mette insieme, sì, un pugno di sole cover, alcune tra le più ovvie possibili, ma l’interpretazione che ne restituisce gode dei benefici di un approccio moderno e, il più delle volte, efficacemente creativo. E, nell’innovativa riproposizione di questi classici è coadiuvato da un esercito di ospiti, tutti chitarristi, utilizzati con sapienza e intelletto abbondanti a garanzia del risultato. Come a dire: a ognuno il suo brano; il più confacente!
Così, già l’iniziale Boom Boom, grazie alla tracimante, incendiaria slide di Dave Hole diventa, rivisitata in chiave blues-rock, uno dei gioielli assoluti del disco. Insieme al successivo Hi Heel Sneakers dove Eric Gales trionfa in fantasiosi, funambolici virtuosismi d’alta quota. Kid Ramos dà prova di grande stile matchando perfettamente con una Quicksand che, nelle sue mani abili, diventa uno spassoso boogie. E sorprende anche la rilettura rockeggiante di Born Under A Bad Sign alla quale Kirk “Eli” Fletcher aggiunge il proprio tono magistrale. Da parte sua, Matty T Wall, ritaglia tre episodi per sé, in formazione a schietto trio e senza ospiti: Stormy Monday, suonata con metà cuore rivolto a Hendrix e l’altra metà ad Albert Collins; I'm Tore Down, qui sensualmente frenata e la conclusiva Crossroads, stravolta in maniera innaturale, a rappresentare l’unico dubbio dell’intero disco. G.R.
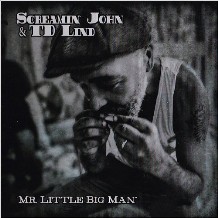
SCREAMIN' JOHN & TD LIND
"Mr. Little Big Man"
Down In The Alley Rec. (USA) - 2019
Rollin' Joanna/The letter/Shame, shame, shame/Jelly roll/Little big man/All your love/Way past midnight/Cold stone and emptiness/Gonna drag ya/Goodnight Irene/Reaper's knockin'
Ciò che aveva preso il via come la, più o meno giocosa, reunion degli Edenstreet, vecchia e oscura formazione rock del Kentucky degli anni ‘90, nel giro di soli due album si è trasformata nell’incarnazione di un’autentica blues band; e ciò che era stato messo a bollire in pentola col precedente Gimme More Time è, qui, giunto a piena cottura.
Questo verace combo, coagulato attorno al chitarrista Screamin’ John Hawkins e al cantante e pianista TD Lind, prodotto dal britannico Glyn Johns, membro della Rock and Roll Hall of Fame e appositamente trasvolato oltreoceano per suggellare il loro bis discografico, si divide equamente tra cinque inediti, scritti da Lind stesso, e sei ben scelte riproposizioni. Mentre i primi strizzano, con decisione, l’occhio al lato più roots della band, in un abbraccio di influenze che parte dai neorleansiani grooves dell’iniziale Rollin’ Joanna e arriva fino al crepuscolo delle note più cantautorali di Cold Stone And Emptiness passando per una Little Big Man che ricorda i migliori Creedence d'annata, le seconde marcano netti i confini dell’anima più blues del gruppo, con una serie di inusuali riletture come The Letter di B.B. King, resa nervosamente chicagoana dalla tagliente chitarra di Screamin’ John o Shame Shame Shame di Jimmy Reed, qui rallentata e vagamente southern nel suo ondulante svolgimento. Sorprende e delizia, infine, la versione per sola chitarra e voce, di Goodnight Irene, melanconico omaggio a una gemma del vecchio Leadbelly. G.R.
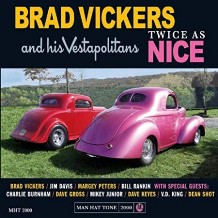
BRAD VICKERS AND HIS VESTAPOLITANS
"Twice as nice"
Man Hat Tone Rec. (USA) - 2019
Worried life blues/Mississippi swamp/Love can win/Close together/Coast to coast/Twice as nice/Red dust/Everything I need/Stealin' stealin'/Look a there look a there/Brooklyn evenings
A chi non ha famigliarità con Brad Vickers e i suoi Vestapolitans questo Twice As Nice potrà fornire un solido e valido contributo esemplificativo alla conoscenza della band nonché un pieno saggio del loro stile e delle cosucce da loro più o meno abitualmente proposte.
Campione di un suono d’antan, Brad Vickers mescola, nel proprio cilindro magico, ogni sorta di influenza roots, aggiungendovi uno stile vocale e strumentale compiutamente allineato alle musiche. Una volta missati gli ingredienti, il coniglio estratto dal cappello sarà un sangue misto e recherà tracce evidenti, nel proprio corredo genetico, di ragtime, hill country blues, jug band blues, jump, roots'n'roll.
La formazione base, che include anche sax, clarinetti e banjoele, viene occasionalmente integrata con nomi di pregio quali Dave Gross, Charlie Burnham, Dave Keyes e Mickey Junior, rispettivamente chitarra, violino, piano e armonica. E il repertorio, che oscilla amabilmente tra brani inediti e rifacimenti annovera, tra le offerte di rilievo, una versione rallentata e downhome del Worried Life Blues di Big Maceo, due sorprendenti riedizioni tratte da Jimmy Reed (Close Together e Everything I Need, quest’ultima travestita da Chicago shuffle) nonché alcuni tributi a un lontano passato con i ripescaggi di un paio di titoli di Will Shade e Tampa Red ai quali la voce, dai gommosi e assonnati riflessi nasali, di Margey Peters, che condivide le incombenze vocali con lo stesso Vickers, conferisce il sapore tipico di un classic blues. Un po’ fuori dal coro, si pone, invece, il lamento indiano di Red Dust; mentre quei conclusivi Brooklyn Evenings (....in the summertime...) sono illuminati a giorno dai felici incisi di chitarra di Dave Gross. G.R.
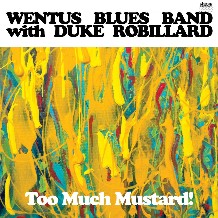
WENTUS BLUES BAND with DUKE ROBILLARD
"Too much mustard!"
Ramasound Rec. (USA) - 2019
Stayed at the party/2:19/Judgement day/First we take Manhattan/She's a killer hot blonde/Right in your arms/Too much mustard/She made my mind/I hear you knockin'/Miranda/You got my love/Selma/Feel so bad/Where have all the songbirds gone/Passionate kiss
Prodotto da Duke Robillard e con la partecipazione attiva dello stesso, tanto come autore quanto come chitarrista, Too Much Mustard! rappresenta la cristallizzazione di quella soluzione collaborativa, nata nei lontani anni ’80, tra il fu chitarrista dei Roomful Of Blues e dei Fabulous Thunderbirds (oggi, uno tra i più rinomati stilisti delle sei corde rimasti in circolazione) e questa band finlandese, dai natali ultra ventennali.
Malgrado l’indubbia perizia con la quale viene affrontato il repertorio, il cd tradisce un tale assortimento di materiale la cui eterogenea genia pare, talvolta, fin eccessiva tanto da far sì che il risultato d'insieme soffra di una qualche forma di disomogeneità. La prova macroscopica di ciò la troviamo ben presto con la riproposta, tra i titoli, di First We Take Manhattan di Leonard Cohen che, pur sottoposta a un coatto trattamento bluesy al punto tale da snaturarla fatica, pur alleggerita com’è nello spirito, a trovare una propria collocazione agiata all'interno del contesto. La band, che storicamente si è sempre fatta interprete di uno stile ben ancorato alla tradizione (tanto da farne, nel corso degli anni, la nordica backing band di artisti come Eddie Kirkland, Kim Wilson, Lazy Lester e Louisiana Red) sembra, qui, volersi concedere una qualche divagazione da consolidate abitudini: ne sono esempio l’iniziale gospel festaiolo Stayed At The Party degli Holmes Brothers o la 2:19, ripescata dalle pagine più “blue” di Tom Waits. Se entrambi questi brani mantengono pressoché intatto il loro mood originale, cambia invece aspetto il Robert Johnson di If I Had A Possession Over Judgement Day (qui, ridotto a semplice Judgement Day!) rilettura tra le più riuscite dell’intera raccolta. Il programma, che oltre alle covers, comprende un cinquanta per cento di brani originali, annovera anche inattese ballads; ma, gli episodi più convincenti, restano quelli maggiormente affini allo spirito primigenio della band. G.R.

JANIVA MAGNESS
"Sings John Fogerty: Change in the weather"
Blue Elan (USA) - 2019
Change in the weather/Lodi/Someday never comes/Wrote a song for everyone/Don't you wish it was true/Have you ever seen the rain/Bad moon rising/Blueboy/Fortunate son/Déjà vu (all over again)/A hundred and ten in the shade/Lookin' out my backdoor
Chi la frequenta con assidua fedeltà sa che, soprattutto con l’avvento dei suoi ultimi album, Janiva Magness ha lentamente e progressivamente cambiato muta sostituendo, alla propria pelle di interprete, un tempo prevalente, quella di pregevole autrice, ormai dominante. Come pure sa - o capisce meglio adesso - che, in Love Wins Again, il primo tra i suoi dischi più recenti, dove tale mutazione ha preso avvio, c’era già, in nuce, l’inconscia anticipazione di questo lavoro. In quel disco del 2016, infatti, la Magness, con la toccante rilettura di una tra le migliori pagine del John Fogerty più celebre, Long As I Can See The Light, gettava, senza saperlo, il seme di Change In The Weather.
Con questo suo nuovo lavoro, dunque, Janiva Magness porta al massimo germoglio quel seme gettato tre anni fa offrendo non solo una personale rilettura, ma l’intero suo disco al songbook di John Fogerty. E lo fa, attingendo tanto dal repertorio più noto e antico, quello del periodo Creedence Clearwater Revival, per intenderci, quanto da quello del Fogerty solista, più recente. Con l’eccezione di un paio di road songs come Lodi (qui, interpretata in duo col cantante country Sam Morrow) e la conclusiva Lookin’ Out My Backdoor, c’è un filo comune che lega i titoli scelti: è quello del Fogerty più sociale. E, in questo filo, vi inciampiamo fin dal brano d’apertura dove il lento groove della versione originale, viene trasformato in un gioioso upbeat dal fresco sapore di gospel domenicale. Ma questa non è l’unica operazione di maquillage sfoderata dalla Magness e dall’ancora confermato produttore Dave Darling: la più sorprendente, tra tutte, è quella di cui è oggetto la celeberrima Have You Ever Seen The Rain, qui di molto rallentata e interpretata, con l’animo contrito di una laica preghiera, nella cornice delicatamente churchy offerta dall’Hammond di Arlan Oscar su un succinto inciso di chitarra bluesy estratto dalle dita di Zac Ross. E, a rendere ancora più prezioso il tributo a uno dei migliori autori della canzone americana, si unisce Taj Mahal in Don’t You Wish It Was True. G.R.

BILLIE WILLIAMS
"Hell to pay"
Autoprodotto (USA) - 2019
Damn/Cold November/Start all over/You/Hell to pay/Hour by hour/Drink from my cup/Lost in the wilderness/My everything/Take these dreams/Ten million sisters
Nuovamente sorretta dall’ottima produzione di Danny Blume e da una band assai sostanziosa, Billie Williams dimostra, con Hell To Pay, il proprio ragguardevole talento di autrice dalla sensibilità schiettamente intimista. I leggeri riflessi castani del suo canto si misurano, qui, con un repertorio interamente autografo, delineato da un rimarchevole, minuzioso lavoro di cesello, scolpito e posato su una base, finemente levigata, di moderno rock’n’soul. A quella cifra aggiuntiva di corpo e rotondità, che gli armonici mancanti le avrebbero donato, la voce della Williams compensa, talora, con spinte improvvise sui sentieri irti e scoscesi del volume. Come in Damn, Cold November o la stessa Hell To Pay che rappresentano buona parte del repertorio più drammatico ed emozionale del disco e che, tra venature rock e fosco blues in minore, non sfigurerebbero affatto nel repertorio di una Beth Hart. Altrove, laddove affronta le pagine più gentili e soulful del proprio racconto (You, Lost In The Wilderness, My Everything, Take These Dreams), quelle in cui si incontrano coloriture musicali più affini al soul calate su tele dei giorni nostri, la Williams appare più naturale, subito avvolta da un’improvvisa, chiara, radiosa luce battesimale. G.R.
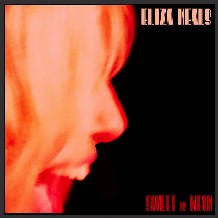
ELIZA NEALS
"Sweet or mean"
E-H Rec. (USA) - 2019- EP
Pawn shop blues/Blackish gray/Bitten by the blues/Livin' with yo mama/Knock knock knockin'/Pawn shop blues (roadhouse)
Cosa può succedere quando due forze primitive, due fuochi - che non voglio dire sacri, ma fuochi sì! - come quello di Eliza Neals, incarnazione singola del trino talento di autrice, cantante e pianista e di Popa Chubby, al secolo Ted Horowitz, autore prolifico, chitarrista energico ed egregio produttore, si incontrano per la via? Succede che le energie di queste singole forze, come passate attraverso funzioni matematiche che ne effettuano la somma, il prodotto, l’elevazione a potenza, vengono portate a rapida esplosione. E succede che, la dicotomia tra 'sweet' o 'mean' evocata nel titolo si risolve ben presto in retorica; cosicché, tra le due, trova riscontro, nella pratica dell’ascolto, soltanto più il 'mean'!
In questo snello, vigoroso EP, Eliza Neals abbandona il piano (affidato, invece, alle sapienti mani di Dave Keyes), per concentrarsi su testi e canto; mentre Popa Chubby ritaglia sulla propria misura, gli abiti del produttore, dell’arrangiatore e, soprattutto, del chitarrista. Il disco che, manco a dirlo, è molto elettrico, concede un po’ di spazio a una coppia di fiati nell’iniziale Pawn Shop Blues; spazio che poi, quasi fosse peccato l’averlo concesso, toglie in chiusura, riproponendo il medesimo brano in versione roadhouse, leggasi depurata dalla presenza di sax e tromba. Ma, in questo trionfo di potenza e sudore che è Sweet Or Mean, l’autentica bellezza la troviamo nella sorpresa: l’acustico Knock Knock Knockin’, piccola perla deposta sul fondo di un fiume d'Ampere. G.R.

PASCAL BOKAR
"American trails"
Savanna Jazz Rec. (USA) - 2019- EP
The blues don't like nobody (feat. Paula Harris)/I wanna see you in my dreams (feat. Paula Harris)/I can tell/Your smile inside my nights/Let it groove/Everytime I see you there
American Trails è il manifesto rappresentativo di una narrazione musicale: quella che racconta di come il bagaglio a mano di sonorità e strumenti ancestrali della natia Africa occidentale, si sia ricongiunto e integrato con l’altro bagaglio, quello più tipicamente americano, contenente blues e jazz. In quest’operazione, diversamente da altre più concettualmente fini, operate in campo jazzistico, i tratti della musica popolare americana, conservano una posizione di rilievo rispetto a quelli africani che, diversamente, si incarnano nell’impiego di strumenti tipici - e, dunque, di tinte timbriche - più che in forme e armonie. Del resto, l’intento di Pascal Bokar, gran maestro di ciò che viene battezzato ‘Afro Blue Grazz sound’ è quello di riunire l’eredità africana con la tradizione americana in un unico, ritmicamente colorito, intreccio sonoro. L’elemento di diversità che questo chitarrista, dalla fluida, atletica virtuosità, introduce in questo suo ultimo, snello EP, è la presenza del balafon, antico parente del vibrafono, al quale si aggiungono banjo, violino e percussioni a creare un mix di poliritmie e accenti inusuali quanto seducenti.
Ad esclusione dell’iniziale The Blues Don’t Like Nobody di Otis Spann, tutti i restanti brani sono inediti che, talvolta, sconfinano nel campo, verde e umido, delle morbide soul ballads. I Wanna See You In My Dreams, dove il chitarrista e cantante duetta amabilmente col pastoso timbro di Paula Harris, ne è limpido esempio. E lo stesso Bokar finisce, poi, per cedere ripetutamente alla tentazione di emulare il George Benson più smooth: quello dell’era in bilico tra gli anni ‘70 e ‘80. G.R.

THE SHAKIN' APES
"The shakin' apes"
Area Sonica Rec. (I) - 2019 - EP
Enjoy the show/Troubles in a week/Better time/Under your sky/Take this/Another way for fun
Non concede il tempo di tirare il fiato, l’esordio, in formato compresso, di questo quartetto sardo votato al culto degli anni ’50, intesi nella loro più schietta manifestazione rock’n’roll. In quanto EP, tutto si gioca sulla breve distanza di una manciata di brani, cosicché il ritmo incalza dal principio alla fine. La chitarra spadroneggia, con sciolta liquidità, su una scena che contende soltanto con l’ottima voce del cantante. Il disco, in verità, segue un po' il successo del brano di apertura, Enjoy The Show, il cui video, sul “tubo”, ha letteralmente spopolato. L’idea è accattivante e originale perché il disco nasce con tutte le intenzioni del concept album, rese esilaranti dal surreale tema di fondo: la narrazione, svolta su sei capitoli, quanti sono i brani, racconta la storia di uno scimmione di nome Marty (quello che ritroviamo affacciato sulla copertina!) la cui esistenza, da scapigliato rock’n’roller, viene stravolta dall’incontro, galeotto, con la bella Daisy.
Questi quattro, accorti, ragazzi d’esperienza, nel riproporre stilemi noti e, a tratti, infarciti con affini richiami di rockabilly e surf, conquistano con l’idea di un lavoro dall’estetica antica, ma dal suono attuale, che si colloca, conseguentemente, in un punto dello spazio-tempo dove il moderno e il vintage s’incontrano faccia a faccia. G.R.
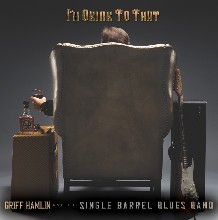
GRIFF HAMLIN & THE SINGLE BARREL BLUES BAND
"I'll drink to that"
Autoprodotto (USA) - 2019
Almost level with the ground/Same to you/Down and out/Someone/Nothing better/Louisiana holiday/Don't lie/Where would I begin/Got to end/Bourbon and a pistol
I’ll Drink To That, ovvero del come assimilare un lessico ben noto e famigliare e ributtarlo nella mischia dopo un massiccio passaggio al trucco.
Il lessico è quello del blues e del R&B suonati da band estese ed erculee, forti di sode sezioni di fiati, con una chitarra a ricoprire, spesso, il ruolo della prima donna. L’operazione è del tutto analoga a quella portata a pieno compimento da B.B. King, in primis e al tempo che fu. Il trucco sta, invece, nell’aver attualizzato quel lessico con sonorità assai moderne e arrangiamenti abilmente rifiniti, in punta di pennello, tanto da tratteggiar le linee di un quadretto musicale dove nulla sfugge al caso.
Griff Hamlin, a oggi principalmente noto per le sue seguitissime lezioni di chitarra via web, pubblica, con I’ll Drink To That, il suo esordio discografico. Sebbene autoprodotto, il disco tradisce l’intenzione di non andare al risparmio, in fatto di musicisti, idee, energie. Il virtuosismo strumentale di Hamlin, talvolta acrobaticamente estremo, difficilmente costringe all’angolo o, peggio, al silenzio il buon gusto per la nota. In più di un’occasione, per esuberanza, ricchezza di suono e agilità strumentale, ricorda le uscite del primo Chris Cain, ma tra le righe di un tal multiforme dischetto, le influenze che si avvertono ci schiudono gli occhi a un orizzonte ben più vasto che spazia dal già menzionato King, ad Albert Collins e, via citando, fino a Stevie Ray Vaughan. Sebbene il brano di apertura omaggi indirettamente Sonny Thompson, mutuando titolo e andamento dal suo celebre Tore Down, il restante programma insiste, ben più marcatamente, su spunti originali e talvolta avventurose progressioni, restituendo la sensazione netta di un lavoro fresco e trascinante. G.R.
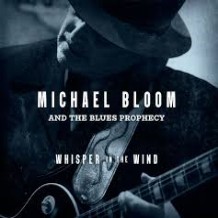
MICHAEL BLOOM & THE BLUES PROPHECY
"Whisper in the wind"
Random Acts Media Rec. (USA) - 2019
Time on my hands/Whisper in the wind/Just can't win/I remember love/Brownsville/Old man blues/Till I met you/No luck at all/Lisa/I ain't got the blues/Dust my broom (feat. Mary Lane)
C’è qualcosa nello stile chitarristico di Michael Bloom che lo rende sinceramente interessante. Si avvertono, sì, influenze varie, ma così tante da amalgamarsi tra loro in modo quasi perfetto ed essere riconoscibili a tratti e al solo orecchio attento. Si ascolti già l’iniziale funk in punta di slide che è Time On My Hands, lo shuffle di I Remember Love con l’ottimo piano di Brant Leeper o il lento No Luck At All che cita, tra le righe (anche quelle del titolo!), Born Under A Bad Sign.
Bloom mescola la poesia dei grandi classici del passato col gusto del fraseggio che gli deriva da fonti le più diverse: dai mormorii di vento della Windy City, Chicago, città responsabile della sua formazione musicale, a Little Milton, Albert King, J.J. Cale. La sua voce, senza troppi fronzoli, fa il giusto paio con la proposta musicale, onesta e diretta, che costituisce il nucleo di questo suo esordio discografico solista. Nel bel mezzo di una buona dose di brani inediti, i classici spuntano con tre piacevoli covers, due delle quali, sorprendono per l’originalità della scelta: Brownsville di Furry Lewis e il torrido slow Old Man Blues del mai ricordato abbastanza Johnny Copeland. Diversamente, la terza scelta, che è la più scontata trattandosi della celeberrima Dust My Broom, ha l’inestimabile pregio di ospitare, quale interprete, l’ottantatreenne chanteuse Mary Lane, contribuendo a rispolverare la leggenda di questa gemma nascosta del Chicago Blues, oggi legittimamente parte del Chicago Blues Hall Of Fame. G.R.

SUNDAY WILDE & THE 1 EYED JACKS
"Sunday Wilde & the 1 eyed jacks"
Autoprodotto (CAN) - 2019
Evil/Love is/Dead man's clothes/Show me mercy/Dead presidents/It hurts me too/My baby's dead/Capture me/Spirits up my friend/Swear you're cheatin'/I guess I didn't hear you right
Il suo timbro di voce restituisce un mix di echi che trova presto il proprio comodo punto di intersezione tra le cantanti di classic blues (Ma Raney, Bessie Smith), le jazz vocalists prima maniera e la contemporanea Amy Winehouse. Il suo stile pianistico, più sommessamente disperso nelle trame dei brani anziché prevalente sulle stesse, emerge in superficie e si concede fiero alla tradizione boogie e honky tonk, sui tasti di un pianoforte vero, soltanto in Dead Presidents e Captured Me. Per il resto, in questo suo ottavo disco, Sunday Wilde da Ontario, Canada, accompagnata da un classic combo con contrabbasso, chitarra e batteria predilige, al pianoforte, di gran lunga le tastiere con le quali crea, spesso, sinistre atmosfere insinuanti e richiami d’altri tempi. La playlist, che insiste ripetutamente e opportunamente sulla sua vena d’autrice, a un tempo, intimista e verace, comprende anche tre rimarcabili remakes: oltre al già citato Dead Presidents di Willie Dixon, lo stesso Dixon ritorna con Evil la cui presente, particolare rilettura, che certo avrebbe raccolto tutte le simpatie della Winehouse, ricostruisce il brano attorno a un aleggiante senso di angoscia e tormento. Terza, e ultima, sorprendente rivisitazione è quella del celeberrimo It Hurts Me Too, portato alla luce dalla versione di Elmore James, ma scritto da Tampa Red e qui riproposto in tonalità mesta e crepuscolare dove la languida chitarra di Ari Lahdekorpi trova la sua tana perfetta. G.R.

ALICE HOWE
"Visions"
Know Howe Music Rec. (USA) - 2019
Twilight/Lovin' in my baby's eyes/Still on my mind/What we got is gold/Bring it on home to me/Too long at the fair/Honey bee/Getaway car/You just never know/Don't think twice, it's all right
In questo gradevole esordio, che si arresta improvvisamente indeciso al bivio tra il sentiero del cantautore e quello dell’interprete, Alice Howe incornicia, nel perimetro levigato e perfetto di semplici ballate folk, tutta la luce calda e cheta del suo liscio, chiaroscurale mezzosoprano.
Nei sentori netti di Greenwich Village, di anni ’60 e finanche di influssi celtici che si avvertono all’ascolto, ritroviamo echi di Mary Chapin Carpenter, Joan Baez o Eva Cassidy. A produrre Visions, disco fatto di arrangiamenti genuini che sottolineano squisite armonie, è Freebo, già bassista di Bonnie Raitt (e la Raitt degli esordi è un’altra evidente figura di riferimento per Alice Howe), Dr. John e Maria Muldaur. A lui, e alla Howe stessa, si aggiungono, a sprazzi, Fuzzbe Morse alla chitarra, John Thomas alle tastiere e John Molo alle percussioni, anche questi musicisti di area West Coast.
Affiancati al pugno di pregevoli brani inediti, che sono poi quelli che, su tutti, convincono appieno, troviamo un gruppo di eclettiche covers. Tra quest’ultime, spicca indubbiamente il Sam Cooke di Bring It On Home To Me, qui gradevolmente riletto in versione ibrida country-soul. G.R.
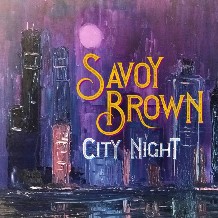
SAVOY BROWN
"City night"
Quarto Valley Rec. (UK) - 2019
Walking on hot stones/Don't hang me out to dry/Payback time/Red light mama/Conjure rhythm/Neighborhood blues/Selfish world/Wearing thin/City night/Hang in tough/Superstitious woman/Ain't gonna worry
Nel 2017, questa band inglese, che vanta ben cinque decenni di storia alle spalle ma, dischi alla mano, non pare dimostrarli, era riuscita nell’impresa di piazzare l’allora ultima fatica, Witchy Feelin’, al vertice della classifica di Billboard, settore blues. Cosa mai ci si sarebbe potuto attendere, dunque, da questo nuovo City Night che, fatti i proverbiali conti della serva, dovrebbe essere, traccia più traccia meno, il loro quarantesimo lavoro? Di certo, nulla che suonasse rivoluzionario - sono lontani i tempi di Toolin’ Bells e Train To Nowhere! -, ma vitale, quantomeno, questo sì.
In tal senso, i Savoy Brown non tradiscono l’aspettativa. Una sporca dozzina di brani inediti, dal suono saturo e pregnante, che riprende la variegata tavola cromatica e i vivaci, gocciolanti colori urbani del disegno di copertina. L’energetico rock-blues che si tinge di Bo Diddley chiamato Hang In Touch; sentori di vintage Texas e di ZZ Top che si affacciano all’orecchio con Don’t Hang Me Out To Dry o Conjure Rhythm. E, tra il cupo voodoo swamp di Superstitious Woman e lo slow Neighborhood Blues, ritroviamo persino inattese inflessioni ska con Payback Time e un certo, non sottovalutabile, appeal radiofonico con l’iniziale Walking On Hot Stones.
Ma, trionfante sotto i riflettori, è sempre il carattere abrasivo ed eloquente della chitarra di Kim Simmonds, fondatore e unico superstite della formazione originale. Formazione che, dato il proprio lungo corso, ha visto l’avvicendarsi, negli anni, di diversi soggetti ma che, da un decennio ormai e ancora qui, annovera la solidità ritmica degli ottimi Pat De Salvo al basso e Garnet Grimm alla batteria. G.R.

TULLIE BRAE
"Revelation"
Endless Blues Rec. (USA) - 2019
Price of the blues/Seven bridges/Mississippi rain/Break these chains/New shoes/Devil in Deville/Ain't no good/Watch her move/Shine/Thank you mom
Dall’hard rocking Price Of The Blues, passando attraverso il gentil regno delle cantautorali ballate, abbondantemente inumidite nel terreno di coltura del soul (Shine, Thank You Mom), fino ad approdare agli immaginari oscuri di tormentate storie di malversazioni e amori andati a male come Break These Chains o la magistrale ballad soul-blues in tono minore Mississippi Rain, Tullie Brae si rivela, con il supporto del produttore Jeff Jensen, qui anche chitarrista, nel suo talento di cantante, autrice e polistrumentista.
Nata e cresciuta nelle chiese della Louisiana tanto che, i suoi trascorsi sanctified sono ben chiari già in quel corale racconto di redenzione che è Seven Bridges, inusuale incrocio di sacro gospel e profane atmosfere da juke joint, la sua provenienza geografica, tuttavia, non trapela per nulla, direi, dalle restanti sonorità di queste tracce che, diversamente, si impantanano talvolta nei sinistri fanghi del Mississippi come nel sulfureo Devil In Deville.
Pur circondata da un caleidoscopio di strumenti - Hammond, piano e chitarre cigar box - di cui è maestra, emerge anche e soprattutto come potente vocalist. Il suo vigoroso e cangiante strumento rosso rame, sa tramutarsi in sottile, trasparente cristallo come contaminarsi di ossido quando si trova in presenza di paludose umidità. Da segnalare, l’armonica di Brandon Santini ospite qua e là. G.R.

ELLIS MANO BAND
"Here and now"
Suisa Rec. (USA) - 2019
Whiskey/Here and now/Where we belong/Goodbye my love/A lifetime/Badwater/Georgia/Bad news blues/I want you back/Jeannine
Alzi la mano chi si ricorda il nome di un qualche musicista svizzero - non voglio dire necessariamente blues - famoso! Io, per dire, rammento giusto, e fama a parte, un tale Hank Shizzoe che, anni or sono, aveva prodotto un discreto (per quantità e qualità) pugno di dischi, alcuni genericamente classificabili come “americana”. Nessun’altro al momento; ma, sicuramente, si tratterà di un mio deficit mnemonico. Beh….non solo i musicisti della Ellis Mano Band arrivano dalla Svizzera e, a giudicare da questo brillante esordio, vanno collocati di diritto, e anche un po’ a scatola chiusa per quelle che sono le mie conoscenze, tra le migliori band d’oltralpe. Ma, singolarmente, pare abbiano curricula che li hanno visti al fianco dei più importati nomi del genere e non solo; svizzeri, ovviamente, e quali che siano!
La Ellis Mano Band giunge, così, a noi a cavallo di un fiero rock-blues, e con una generosa manciata di brani inediti, interpretati dalle modulate venature di torba della potente voce di Chris Ellis. Arrangiamenti e sonorità di prim’ordine confezionano un repertorio che in più occasioni rievoca atmosfere di pertinenza di Paul Rodgers e dei suoi Free, come nei due protoblues in minore A Lifetime e Bad News Blues. Influenze evidenti di Led Zeppelin le troviamo in Badwater come sentori di Allman Brothers emergono tra i fumi dell’iniziale Whiskey come in un paio di ballate rock ascoltate per la via.
Talvolta arricchito da Hammond e fiati, il quartetto base non sbaglia colpo fino a spiazzare tutti con quella conclusiva pennellata fuori tela che è Jeannine, moderno e schietto omaggio a New Orleans, alla sua second line e alla cornetta di Buddy Bolden. G.R.

CARLTON JUMEL SMITH
"1634 Lexington Avenue"
Timmion Rec. (USA) - 2019
Woman you made me/Love our love affair/Remember me/Help me (save me from myself)/Ain't that love/This is what love looks like/You gonna need me/I'd better/We're all we got/I can't love you anymore
La vocalità di Carlton Jumel Smith, dalla superficie scabra, di secco legno scheggiato, trova la propria dimora d’elezione sul finire del disco, in quella We’re All We Got che tanto ricorda il Curtis Mayfield socialmente ispirato d’un tempo, come nel fuoco controllato della conclusiva I Can’t Love You Anymore brano che, in una vegetazione fitta di ballate soul di antica scuola, aggiunge un torrido sentore di blues in tonalità minore.
In barba a un repertorio interamente composto da inediti, 1634 Lexington Avenue, è un disco che guarda fisso al passato, alle sonorità di Curtom e Motown in primis, tanto che pare essere stato infilato in una bella macchina del tempo e arrivato a noi, oggi, dalla lontana prima metà dei ’70. E’ la materializzazione di una joint venture, questa, tra la Timmion, etichetta finlandese, e la ben nota Daptone di Brooklyn, di cui la compianta Sharon Jones fu stella cometa. E, infatti, questo disco non sarebbe affatto dispiaciuto alla Jones che, con Jumel Smith condivide, come evidente nell’intero disvelarsi di questa gustosa operetta, la medesima estetica retro soul.
Sebbene, a orecchio, non se ne abbia contezza, l’origine nordica della band di Smith è tradita soltanto dai nomi dei propri componenti, riportati nelle note di copertina. La padronanza del genere, per stile e timbrica, è invero pienamente credibile tanto che, non ci stupiremmo se, questi musicisti provenissero, diversamente, da Detroit o Chicago.
Più che nelle, peraltro, poche occasioni laddove il ritmo rallenta, lo strumento vocale di Jumel Smith trova maggior agio in episodi upbeat come Woman You Made Me o This Is What Love Looks Like. Dimostrazione di quanto il soul primigenio continui, ancor oggi, a ispirare, queste tracce, che sono vino novello intrappolato nel vetro d’una bottiglia d’epoca. G.R.

FORTY FOURS
"Twist the knife"
Rip Cat Rec. (USA) - 2019
Cuttin' deep/Sugar you/Howlin'/Champagne and reefer/Too many drivers/Rosie/Helsinki blues/44's shuffle
Quarta pubblicazione per la band losangelena che fu prodotta, all’epoca del suo esordio, da Kid Ramos, appena fuoriuscito dalle fila dei Fabulous Thunderbirds.
Come afferma il leader stesso Johnny Main, Twist The Knife è da intendersi come un disco tributo alle fonti di ispirazione del quartetto che, con un certo agio, possono essere individuate, già ad un primo, sommario ascolto, principalmente in Muddy Waters, Howlin’ Wolf e Lightnin’ Hopkins (quello elettrico!) o, più genericamente, in quel Chicago blues anni ’50 che tanta scuola ha fatto e che, ancora oggi, tanti allievi sembra avere.
Sebbene il Cuttin' Deep di apertura smentisca questo approccio tradendo la netta influenza di Albert Collins, si capisce, dal resto del programma, che i numi tutelari di cui sopra, oltre che fonti di ispirazione, sono diventati anche fonti di emulazione. Si ascolti, per esempio, la voce di Main inseguire l’impronta canora del Lupo in Howlin’.
La band attuale comprende, oltre allo stesso Main, Eric Von Herzen all’armonica (già ascoltato con The Atomic Road Kings di Big Jon Atkinson), Mike Hightower al basso, Gary Ferguson alla batteria e l’ormai leggendario Junior Watson alla chitarra.
Ma non è tutto Chicago blues quello che brilla qui se, oltre al brano d’apertura, ne troviamo un secondo che si smarca dalla linea del tributo stilistico ai citati santi del calendario ed è quel Rosie di Doyle Bramhall II che vira acido verso suoni più psichedelici. Oltre che Helsinki Blues, scritto e cantato come se fosse James Harman a farlo. G.R.

TERRY ROBB
"Confessin' my dues"
Niasounds Rec. (USA) - 2019
Butch Holler stomp/Still on 101/How a free man feels/It might get sweaty/Heart made of steel/Now vestapol/Darkest road I'm told/Three times the blues/Confessin' my dues/Death of Blind Arthur/High desert everywhere/Keep your judgment/Blood red moon
Lo potremmo chiamare il Tommy Emmanuel del blues. E come Emmanuel, Terry Robb offre un equilibrato connubio tra virtuosismo ed eleganza, invenzioni melodiche e ritmiche, gusto estetico e senso dell’armonia, arditi cambi di accordo, il senso di famigliarità con quella tradizione che abbraccia amorevolmente blues, country, jazz, ragtime nonché una occasionale propensione all’impiego dei tempi dispari.
Robb imbraccia tanto l’acustica quanto la resonator guitar e si rivela, in Confessin’ My Dues, tanto in solitaria quanto accompagnato da un paio di musicisti di pari estro e classe come Dave Captein e Gary Hobbs, rispettivamente basso e batteria. L’approccio, fresco e unico, di questi due occasionali comprimari fa il paio con il telepatico, intenso interplay collettivo che sanno creare. E non solo: Captein e Hobbs sembrano talvolta scambiarsi i ruoli laddove il contrabbasso assume una veste prettamente ritmica e la batteria, quasi fosse nelle mani di un novello Elvin Jones insegue, in un affannato controcanto, teso e muscolare per timbriche e accenti, la linea melodica. Ne sono franchi esempi Heart Made Of Steel e, più ancora, Three Times The Blues.
Dal punto di vista acustico, l’album unisce lieve intimità e vigorosa potenza. E, in quel tour de force chitarristico che è questo disco, l’estro emerge subito col bollore del primo Butch Holler Stomp e si mantiene costante per tutta la distanza dei tredici inediti presenti.G.R.

GEORGE BENSON
"Walking to New Orleans - Remembering Chuck Berry and Fats Domino"
Provogue Rec. (USA) - 2019
Nadine (is it you?)/Ain't that a shame/Rockin' chair/You can't catch me/Havana moon/I hear you knocking/Memphis, Tennessee/Walking to New Orleans/Blue monday/How you've changed
Con questa ultima uscita, George Benson stupisce su più fronti: per repertorio, produzione e per la scelta, sorprendente, di mettere il proprio strumento quasi in secondo piano.
Come già sottolinea il titolo stesso, il repertorio affrontato in Walking To New Orleans vorrebbe essere, idealmente, un doppio tributo: a Chuck Berry e Fats Domino; due personaggi che, sicuramente, poco hanno a che spartire con le origini e la storia musicale di Benson, legata alla chitarra jazz e a capiscuola dello strumento come Wes Montgomery e Charlie Christian.
Però, Benson, non è nuovo ai tributi e, a far data dagli anni ’80, neppure a una certa vocalità smooth jazz tanto che, nel 2013, il suo soffice crooning ha affrontato il songbook di un gigante come Nat King Cole.
In termini di stile, Benson deve, dunque, assai poco a progenitori del rock’n’roll come Berry e Domino; malgrado ciò, questo disco, che assomiglia tanto a una panoramica gitarella tra la St. Louis del primo e la New Orleans del secondo, è tutto un concentrato di ghiaioso blues e spavaldo R&B di antica scuola. Prodotto da Kevin Shirley, lo stesso di Joe Bonamassa, Aerosmith, John Hiatt e altri ancora, Walking To New Orleans lascerà un po’ delusi quelli che attendono enfasi e riflettori, puntati tutti sull’improvvisazione chitarristica. Diversamente, si potranno assaporare gustosi ed estrosi interventi pianistici, alcuni in perfetto stile neorleansiano, opera e frutto del talento di Kevin McKendree. G.R.
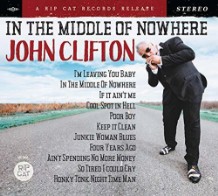
JOHN CLIFTON
"In the middle of nowhere"
Rip Cat Rec. (USA) - 2019
I'm leaving you baby/In the middle of nowhere/If it ain't me baby/Cool spot in hell/Poor boy/Keep it clean/Junkie woman blues/Four years ago/Ain't spending no more money/So tired I could cry/Honky tonk night time man
Avevamo appena riposto nello scaffale Nightlife, l’album di John Clifton edito nel non così lontano 2018, che già ci arriva, calda calda tra le mani, questa sua novella ciambellina. Cantante e armonicista californiano, Clifton non batte nessuna nuova via; ma quella che ha musicalmente intrapreso - quella Highway 99 idealmente raffigurata in copertina e che attraversa Fresno, Modesto, Stockton e altre polverose cittadine del vecchio west - la affronta da esperto professionista del genere.
Il format, come la band, sono gli stessi del disco precedente. Ora come all’ora, il repertorio è equamente ripartito tra inediti e alcune ben scelte cover. Ma qui, a differenza di Nightlife, si registra un’atmosfera decisamente più affilata e convinta. Il suono s’è fatto perentorio; la penna, più sicura e sferzante, talvolta anche nell’immaginifico uso dell’ironia. Tanto che, malgrado riproponga, con singolare magnificenza e personale cura, alcune perline rubate ad Howling Wolf (Poor Boy), Junior Wells (So Tired I Could Cry) e Merle Haggard (Honky Tonk Night Time Man), buona parte della differenza la fanno proprio quegli inediti come la title track, ristretto infuso di country blues e i sagaci versi di brani originali come Keep It Clean o Junkie Woman Blues.
Con Cool Spot In Hell e Ain’t Spending No More Money Clifton offre al popolo, inclusi nel prezzo, due masterclass in armonica cromatica. E, sebbene i duelli di ance e corde col singolare chitarrista Scott Abeyta non manchino, questo disco mette opportunamente sotto i riflettori anche l’estro armonico e l’abilità tecnica di Bartek Szopinski, pianista rivelazione per versatilità, virtuosismo e finezza interpretativa. G.R.

GARY CLARK JR.
"This land"
Warner Bros Rec. (USA) - 2019
This land/What about us/I got my eyes on you (locked & loaded)/I walk alone/Feelin' like a million/Gotta get into something/Got to get up/Feed the babies/Pearl Cadillac/When I'm gone/The guitar man/Low down rolling stone/The governor/Don't wait 'til tomorrow/Dirty dishes blues/Highway 71/Did
Quando si arriva ad ascoltare, sul finire di This Land, quel viscerale blues elettrico che è Dirty Dishes Blues, improvviso, chiaro e sostanzialmente unico tributo alla tradizione qui presente, si ha come la sensazione che quello sia un brano messo lì un po’ per caso: quasi a lavarsi la coscienza. Una coscienza inquinata dal peccato di aver pubblicato un lavoro che, diversamente, col blues, non avrebbe molto a che fare. E così ce ne ricordiamo, metaforicamente parlando, soltanto in punto di morte: del disco!
Gary Clark Jr., chitarrista, cantante e autore texano contemporaneo, è stato salutato, fin dai suoi esordi, come una delle avanguardie del genere; uno di quegli artisti emergenti, in grado di traghettare la gloriosa, sulfurea tradizione del blues, nel nuovo secolo e verso nuovi adepti. Lui, la storia di questa musica, di certo, la conosce bene; la chitarra la sa suonare e i compiti a casa li ha fatti tutti quanti, ma la lezione sembra quasi l'abbia imparata a memoria più che averla metabolizzata e ridotta a proprio patrimonio.
Sebbene sia un disco alquanto ambizioso, nei testi come nelle musiche; apertamente e contemporaneamente politico per alcune esplicite tematiche trattate; seducente, per come concepito e trascinante per quanto ben suonato, This Land non contiene nulla di rivoluzionario e non si discosta da quel rock nero - chiamiamolo così - commisto a funk, reggae e pop, già sentito prima per tramite di Lenny Krawitz, Ben Harper e creature similari, Prince incluso e da tutti i loro padri putativi. Nulla di male in tutto ciò, beninteso, e considerati anche i rimarchevoli risultati ottenuti. Ma se l’intenzione è quella di coniugare in modo credibile ed efficace, modernità con tradizione, temo che Fantastic Negrito, Kenny Smith coi suoi recenti esperimenti e persino un arzillo ottantenne come Bobby Rush la sappiano ben più lunga di Gary Clark Jr. G.R.

VEGAS STRIP KINGS
"Jackpot!"
Gutbukit Rec. (USA) - 2019
Rotgut run/It ain't/Jesus on the dash/Lately/Screeching halt/Take it easy/Back to you/V8 Ford/Pawnbroker/Life on me/Same thing/Sharp as a razor
A guardarli sulla copertina ci si convince, già prima ancora di ascoltarli, di aver capito tutto dei Vegas Strip Kings. Ma attenzione! La tentazione di declassarli d’ufficio, traditi dall’estetica, al semplice seppur nobile rango di party band, sarebbe esercizio troppo facile. Tant’è, basta prestare orecchio all’enigmatica, introduttiva Rotgut Run, che ben concentra e riassume le migliori idee meticce di cui Jackpot è pervaso, per capire che, malgrado l’energia e lo stile frizzante tipici di formazioni di quella risma, i Kings sono, in realtà, qualcosa d’altro; qualcosa di più! Almeno quando osano di più.
Nati sulle ceneri di un precedente, interessante combo di roots/Americana come Contino, i Vegas Strip Kings sono il risultato di un riuscito caleidoscopio idiomatico, la felice amalgama che ingloba swing, country, rock’n’roll, blues, honky tonk, cajun e musica mariachi riusciendo, in più occasioni, a ben omogeneizzare il tutto grazie a idee che si trasformano in sagaci arrangiamenti e guizzi di originalità. Spesso è il meraviglioso impasto tra sax (alle ance c'è Jimmy Carpenter) e accordion o armonica a dare vita a questo caratteristico mix timbrico e Screeching Halt, Pawnbroker, Back To You o il funk Hold On sono i luoghi sonori dove meglio si realizzano questi intrecci. Pressochè nulla, qui, resta intatto tanto che anche uno schietto, tradizionale slow blues come Lately vira, all’apice del suo svolgimento, con improvvisi raddoppi di tempo e una insinuante slide guitar, verso qualcosa che riecheggia arie degli Allman Brothers. E pure Jesus On The Dash, che parrebbe quasi strappata di bocca a Willie DeVille, alla fine lascia un retrogusto diverso. Ma buono. G.R.

ATOMIC ROAD KINGS
"Clean up the blood"
Bigtone Rec. (USA) - 2019
I've got time/Rumors/In arms reach/Have your way/My way back home/Clean up the blood/Candy man/Ain't for me/You got to change/Two sided story/Vibrations/Back down south
Ascoltare questo disco equivale a entrare in una moderna macchina del tempo progettata per viaggi a senso unico e, necessariamente, a ritroso. In Clean Up The Blood, tutto odora di vintage: tecniche di registrazione (in rigoroso mono), foto, grafica e, ovviamente, il sound! Gli anni ’50 del blues non sono mai stati meglio impressi su lastra, riprodotti e, forse anche, riletti, come in questo disco che vede apparire in trasparenza, dietro il mascherante velo degli Atomic Road Kings il giovane talento Big Jon Atkinson, chitarrista, cantante, autore, nonché appassionato collezionista-restauratore di valvole e marchingegni d’epoca, amplificatori in primis e l’armonicista Eric Von Herzen da Orange County, già in forze con Walter Trout, Kid Ramos e Junior Watson.
Atkinson dimostra qui, come già in precedenti uscite, di padroneggiare assai bene non solo il suono di quel periodo, ma anche la scrittura e le tematiche, talvolta riproposte in una chiave lirica originale e sagacemente aggiornata. In questo trionfo di chitarre nervosamente affilate dove, ad Atkinson, si alternano altri tre assi di rigida osservanza del verbo come Scott Smart, Danny Michael e Tony Delgado, la Chicago storica, tanto quella del Southside come quella del Westside, ritornano a splendere con colori sorprendentemente vividi e penetranti. Immersa in un mare di inediti, Two Sided Story, resta l’unica cover presente. G.R.
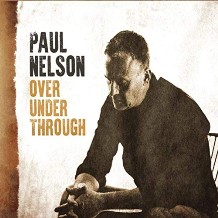
PAUL NELSON
"Over under through"
River Wide Rec. (USA) - 2019
Go down Ezekiel/Ghost in the basement/Color it blue/Secret/Lay a little/Alice Mullin/I walk the line/Relative work/Silent majority/Over under through/There is weeping
Caso di omonimia da non confondere affatto con quell’altro Paul Nelson che fu chitarrista e produttore nonché anima e sostegno, morale e pratico, dell’ultimo Johnny Winter.
Diversamente dall’altro, dunque, questo Paul Nelson arriva dalla East Coast e si muove dentro un perimetro stilistico dai tratti spesso intimisti e ovattati, all’interno del quale si manifesta una spiccata vena più che cantautorale, decisamente poetica ed evocativa: nei testi come nelle musiche. Facili sarebbero i rimandi a personaggi come Amos Lee o Lyle Lovett, ma la penna del nostro Nelson, qui felicemente sposata a bostoniani talenti quali il chitarrista Kevin Barry (che ricordiamo protagonista, nella prima metà degli anni ‘90, nei dischi Audioquest del gran ritorno di Mighty Sam McClain), l’angelica folk vocalist Kristin Cifelli o ancora il cantautore Ellis Paul, presente come ospite ai cori, materializza piacevoli sorprese.
Spalancato sulle atmosfere misteriose e chiaroscurali dell’iniziatico blues Go Down Ezekiel, Over Under Through si regge non soltanto su solidi pilastri lirici e musicali, ma anche sulla vocalità stessa di Nelson il cui strumento, dal registro afono e gentilmente strozzato, ben si cala nell’incavo più profondo di questa singolare raccolta che mantiene, lungo buona parte del suo svolgersi, il timbro peculiare dell’opera acustica – la punta massima di amplificazione si raggiunge con Silent Majority - pur non essendola. Con il caratterizzante ingresso del flicorno, il tempo dispari di Ghost In The Basement si apre a squarci di jazz così come Alice Mullins vibra su corde che risuonerebbero facilmente con quelle di un Van Morrison. E i veri gioielli arrivano, su un intro dalle movenze indiane, con il brano omonimo e, di nuovo, con la sola cover presente, quella I Walk The Line di Johnny Cash qui restituita, complice Ellis Paul, in una inusuale versione meditativa. G.R.

CARA BEING BLUE
"Grit"
Autoprodotto (USA) - 2019
Grit/Crocodile man/Leave me in flames/One day/You don't wanna/Skippin' stone/Old feelin'/Kind kinda man/My doggie/Some fun
Sonorità moderne, dai tratti blandamente rockeggianti, su un tappeto di predominante tradizionale intreccio, delineano gli eclettici contorni di Grit che, lasciato da parte un precedente EP, può serenamente essere considerato come l’esordio ufficiale di Cara Being Blue nell’usuale mondo del long playing.
Nativa di Boston e, all’epoca degli esordi, premurosamente sostenuta dalla locale regina del genere Shirley Lewis, Cara Being Blue (al secolo Cara Lippman) in tempi recenti s’è trasferita in quel di Nashville e ha assemblato un combo di musicisti di prim’ordine tra i quali spiccano, senza meno e per palese virtuosismo, Val Lapesku e Tim Gonzalez, rispettivamente chitarra e armonica.
La gentilezza del suo strumento vocale si pone in piacevole antagonismo con il misurato amperaggio sprigionato da una band alla quale si aggiungono un paio di rimarchevoli chitarristi ospiti come l’ex Allman Brothers Band Jack Pearson e il newyorkese Dave Fields. Le migliori pagine di questo disco, per tematiche e stile, a iniziare proprio dall’omonimo brano di apertura, parrebbero quasi scippate da qualcuna delle ultime pubblicazioni di Shemekia Copeland, sulla cui bocca, pezzi come la declamatoria e orgogliosamente femminista Grit o ancora la neworleansiana Crocodile Man si troverebbero a loro indubbio agio. G.R.

